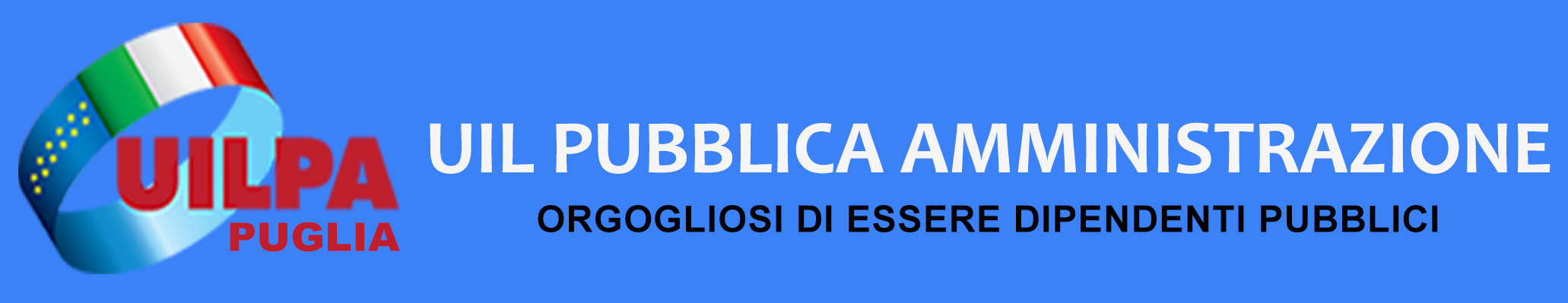Legge di Bilancio 2021
A cura della Segreteria Nazionale:
Comma 849Dal 2023 in poi sono previsti risparmi di spesa nei Ministeri pari a 350 milioni di euro all’anno. In parte, si tratta di tagli già previsti dalle leggi di bilancio de-gli anni scorsi, ma gli importi vengono ora rideterminati in aumento. L’elenco completo è contenuto nell’allegato L.Da notare che i “risparmi” (leggi: tagli alle risorse da destinare alla spesa pub-blica) delle amministrazioni centrali dovranno derivare da “processi di razio-nalizzazione organizzativa” degli enti interessati. Vediamo nel dettaglio alcuni esempi dei nuovi tagli che scatteranno dal 2023 in base alla ricordata Tabella L: Ministero del Lavoro: 1 milione di euro in meno per i diritti so-ciali le politiche sociali e la famiglia; Ministero della Giustizia: 7 milioni e 200mila euro in meno per la giustizia civile e penale; Ministero degli Affari Esteri: 7 milioni e 100mila euro in meno per la promozione della cultura italiana nel mondo; Ministero dell’Istruzione: 6 milioni e 800mila euro in meno per l’istruzione del primo e secondo ciclo;
Ministero dell’Interno: 40 milioni di euro in meno per l’ordine pubblico e la sicurezza, compreso il soccorso civile; Ministero delle Infrastrutture: 3 milioni di euro in meno per la mobilità sostenibile e i trasporti; Ministero dell’Università e della Ricerca: 10 milioni di euro in meno per il sistema universitario e formazione post-universitaria; Ministero della salute: 10 milioni di euro in meno. Ma i tagli non riguardano solo le amministrazioni centrali: un’analoga sforbiciata da 350 milioni di euro toccherà anche a Regioni, Comuni e Province autonome (commi 850-853). Come sempre in questi casi il legislatore assicura che non vi saranno ripercussioni sui livelli dei servizi offerti dalle amministrazioni interessate, in quanto i tagli delle risorse (burocraticamente definito “maggior concorso alla finanza pubblica”) saranno compensati da un “efficientamento della spesa derivante dalla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro”. In altri termini: più pressione sulle strutture operative della p.a. in cambio di minore spesa pubblica. Comma 854 Contiene la programmazione di spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato da effettuare nei Ministeri. Si tratta, in larga misura, di assunzioni già programmate negli anni precedenti per cercare di contrastare il progressivo svuotamento degli uffici pubblici in atto da alcuni anni, ma siamo ben lontani da un progetto ad ampio respiro di investimenti nelle risorse umane del settore pubblico in vista di un autentico ed esteso rinnovo generazionale. Senza en
trare nel dettaglio dei profili da assumere in ciascuna amministrazione (commi 855 e successivi), è interessante notare che la spesa prevista per questo blocco di nuove assunzioni ammonta a circa 36 milioni di euro nel 2021, che salgono a circa 167 milioni nel 2022 e a poco più di 300 milioni nel 2023. Da qui in poi la cifra rimane praticamente stabile, raggiungendo il tetto massimo di 315,4 milioni di euro nel 2033 e per tutti gli anni successivi. Al riguardo, non possiamo fare a meno di notare che i risparmi di spesa previsti dal 2023 in poi serviranno, quasi per intero, a finanziare le nuove assunzioni di personale a partire dallo stesso anno. In ogni caso, le risorse stanziate garantiranno l’assunzione stabile di circa 5.000 unità di personale nei servizi che fanno capo alle amministrazioni del nostro comparto: non molte, in verità, se consideriamo che le Funzioni Centrali hanno perso circa 30.000 unità di personale negli ultimi 5 anni ed almeno altrettante ne perderanno per raggiunti limiti pensionistici entro il prossimo triennio. Comma 870 Con questa disposizione sarà possibile riutilizzare in contrattazione collettiva integrativa (a livello di singolo ente) i risparmi di spesa conseguiti nel 2020 dalle amministrazioni pubbliche per mancata erogazione di straordinari e buoni pasto durante l’emergenza Covid. Le risorse in questione serviranno a finanziare i trattamenti economici accessori correlati alla performance e al welfare integrativo. La norma, in sé stessa, va giudicata positivamente in quanto recepisce lo spirito delle richieste sindacali, in particolare per quanto riguarda la rimozione del tetto massimo di spesa per la contrattazione integrativa: si tratta, come è noto, del vincolo a suo tempo imposto dalla “riforma Madia”, in base al quale, a partire dal 2017, in ciascuna amministrazione non è consentito superare il corrispondente importo del 2016.
È evidente che se un vincolo del genere fosse stato mantenuto, l’utilizzo dei risparmi di gestione al tavolo sindacale sarebbe stato reso di fatto impossibile. Per contro, va detto che la cifra da rimettere in gioco attraverso la contrattazione decentrata (pari complessivamente a 44,53 milioni di euro per tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)1 è, con ogni probabilità, assai inferiore ai risparmi effettivamente conseguiti dalla P.A. nel corso del 2020 a seguito dell’adozione generalizzata dello smart-working obbligatorio durante la pandemia: una cifra sulla quale, tuttavia, il governo non fornisce alcuna quantificazione ufficiale alla quale poter fare riferimento. Comma 925 In termini di prospettive per la qualità dei servizi non appare purtroppo rassicurante il contenuto della disposizione che sancisce il ritorno in grande stile del precariato nelle amministrazioni centrali, in particolare nel Ministero della Giustizia, dove si prevede l’assunzione di oltre 1.000 unità con contratto a termine di 12 mesi per smaltire l’arretrato negli uffici giudiziari. Siamo di fronte alla ripresa di una cultura che speravamo definitivamente superata, almeno nella p.a.: quella degli operatori usa e getta, da assumere per un periodo di tempo limitato in relazione a esigenze contingenti (da soddisfare con criteri più o meno clientelari) e sganciate da qualsiasi programmazione a lunga scadenza. Per farsi un’idea di quello che intendiamo dire, basti pensare che secondo i dati ufficiali della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2018, 1. La lista comprende tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.
i precari a tempo determinato in servizio nell’intero comparto delle Funzioni Centrali sono meno di 1.500… un livello molto inferiore a quello di 15 o 20 anni fa, ottenuto grazie all’incessante azione del sindacato che ha portato alla graduale stabilizzazione di quasi tutti i rapporti a termine nel comparto. Comma 959 Eccoci ai tanto strombazzati (dal governo) “4 miliardi di euro” per il rinnovo contrattuali dei pubblici dipendenti relativo al triennio 2019-2021. Tanto per cominciare, si tratta di un arrotondamento ad uso mediatico, in quanto l’importo reale è pari a 3 miliardi e 775mila euro, ovviamente lordi… ma questo sarebbe il meno. In realtà, la cifra stanziata nella legge di bilancio 2021 ammonta a soli 400 milioni di euro (lordi). Come si arriva, allora, ai famosi 4 miliardi (o meglio, 3,775)? Con una magia contabile: sommando, cioè, tutti gli stanziamenti già decisi dal 2018 ad oggi. Soldi che – si badi bene – in buona parte sono già stati spesi nel 2019 e nel 2020 con la corresponsione dell’Indennità di vacanza contrattuale (IVC), le cui risorse vengono appunto ricomprese nel monte complessivo, anche se di fatto non esistono più. Ma le sorprese non sono finite: bisogna infatti considerare che, come chiarito nel precedente comma 869, le risorse stanziate servono a coprire anche il ri-finanziamento del piccolo incremento aggiuntivo (c.d. “elemento perequativo”) che nel CCNL 2016-2018 fu destinato ai livelli retributivi più bassi. Non basta, perché dal mucchio complessivo occorre sottrarre anche le risorse necessarie per le anticipazioni sui fondi per il trattamento accessorio del personale dei comparti sicurezza – difesa e soccorso pubblico. Senza scomodare il calcolo infinitesimale, si può valutare con ragionevole approssimazione che con ciò che rimane dei 3,775 miliardi a disposizione sarà possibile corrispondere un incremento medio mensile delle retribuzioni dei dipendenti statali di
molto inferiore ai 105 euro lordi a regime pro-capite annunciati da qualche famoso commentatore su qualche famoso giornale economico-finanziario (anzi, forse persino inferiore a quello del triennio 2016-2018, che fu pari ad 85 euro lordi medi). Un’ultima osservazione: pochi si soffermano sul fatto che in questa fase di dilaganti (ancorché necessari e giustificati) incentivi fiscali e contributivi in favore delle imprese e dei dipendenti del settore privato, gli incrementi retributivi in favore di pubblici dipendenti rappresentano l’unica voce di spesa pubblica che comporta un ritorno positivo in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, dal momento che alle maggiori spese correnti corrispondono maggiori entrate tributarie e contributive. La relazione tecnica al comma 959 spiega infatti che “sulla base delle stime prudenziali delle entrate correlate alle trattenute f iscali e previdenziali sui dipendenti pubblici”, la quota della spesa per redditi che rientra nelle casse delle pubbliche amministrazioni a titolo di maggiori entrate tributarie e contributive (c.d. “effetti indotti”) è pari circa al 49%.